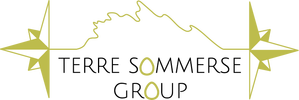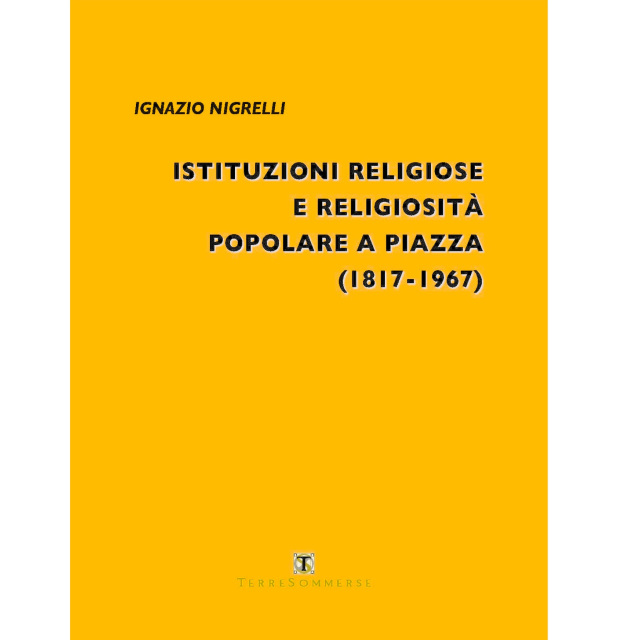- Store
- >
- Categorie
- >
- Terre Sommerse Edizioni
- >
- Libri
- >
- Saggistica e Dintorni
- >
- Saggistica
- >
- ISTITUZIONI RELIGIOSE E RELIGIOSITA' POPOLARE A PIAZZA (1817-1967) di Ignazio Nigrelli
ISTITUZIONI RELIGIOSE E RELIGIOSITA' POPOLARE A PIAZZA (1817-1967) di Ignazio Nigrelli
Nota del curatore
È probabilmente nel primo semestre del 1968 che Ignazio Nigrelli, dopo un quindicennio quasi completamente dedicato all’attività politica, ritorna alla storia, sua passione giovanile che aveva prodotto la tesi di laurea sulla fondazione federiciana di Gela e la parentesi di storia contemporanea che lo aveva visto collaborare con i massimi storici siciliani a metà degli anni Cinquanta, nell’ambito degli studi sui Fasci siciliani.
L’occasione è data dal centocinquantesimo anniversario della erezione della Diocesi di Piazza, che lo spinge a dedicarsi alla ricostruzione delle tradizioni religiose e, in particolare, alla storia delle confraternite.
La molla che lo spinge a dedicarsi a questo tema, però, non è solo l’importante anniversario, ma l’aver ritrovato in un cumulo di rifiuti, durante una delle sue solite passeggiate serali lungo le vie del centro storico, una scatola con alcune decine di documenti antichi: erano i Capitoli di alcune delle storiche confraternite di Piazza e qualche altro documento rilevante. Ne attribuì la responsabilità a un qualche prelato che aveva fatto pulizia nella sua chiesa e, visto anche lo stato di abbandono in cui versavano tutti gli archivi di proprietà ecclesiastica in quegli anni, nei giorni immediatamente successivi fu combattuto tra consegnare la documentazione alla Biblioteca comunale o conservarla per poterla studiare con calma, cosa che poi fece.
Ma i sentieri della ricerca, come quelli della vita, non sono mai prevedibili e così, dopo avere dedicato i pomeriggi di alcuni mesi a lavorare su quei documenti, riscontrandoli nell’Archivio di Stato di Caltanissetta, mentre continuava a svolgere attività politica militante come consigliere comunale e dirigente provinciale del PCI, fu quest’ultima passione a prevalere. Così tornò a dedicarsi nuovamente a tempo pieno all’attività politica in un torno di tempo in cui le istanze sociali della sinistra conquistavano fasce sempre crescenti di cittadini e c’era l’impressione che le classi popolari potessero finalmente guidare le città e lo Stato.
Al tempo stesso, però, dedicava la sua azione di studioso e intellettuale ad attività più divulgative che avrebbero portato di lì a poco, nel 1972, alla pubblicazione della prima guida turistica illustrata (in bianco e nero!) di Piazza Armerina, commissionata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo e firmata insieme a Nino Vullo.
Dal 1968, per 50 anni, il suo manoscritto e il suo dattiloscritto con i tradizionali caratteri della Olivetti lettera 22 e l’inchiostro blu, pieno di correzioni e integrazioni a mano, sono rimasti in un faldone nella libreria di fronte alla scrivania del suo studio, nel ripiano più in basso a sinistra.
Perché Ignazio Nigrelli scelse di non pubblicare più quel testo? Né di rimetterci mano magari dopo avere abbandonato del tutto la militanza politica trentennale dopo il 1976?
Non lo sappiamo, ma possiamo fare solo delle congetture.
Gli anni tra il 1972 e il 1976 furono quelli di massimo impegno nel Consiglio comunale e, in particolare, nella Commissione edilizia in cui era stato eletto (e con lui, per la prima volta, era entrato un rappresentante dell’opposizione di sinistra). Erano tempi in cui, in assenza di Piano regolatore e con un Programma di Fabbricazione risalente al 1970, sovradimensionato per quasi 38 mila abitanti, la speculazione edilizia viveva anni d’oro con tecnici e imprese direttamente interessati alle attività di nuova costruzione e stabilmente presenti in Consiglio comunale e in commissione.
La battaglia per le regole e contro la speculazione edilizia veniva facilmente ritorta contro i suoi sostenitori accusati di volere bloccare il progresso e impedire il lavoro a quella classe operaia impegnata nell’edilizia che pure rappresentavano. Una battaglia sempre più solitaria di cui restano numerosi documenti e che mise a dura prova il suo fisico fino all’infarto della primavera del 1976 che, insieme alla delusione per la tiepidezza degli organismi di partito rispetto a quei temi, lo indusse ad abbandonare definitivamente l’attività politica.
Questa motivazione, però, può essere valida limitatamente a quel periodo e non spiega perché, da quell’anno in poi, tornato a tempo pieno all’attività di ricerca si sia dedicato ad altri temi: dalla storia medievale in particolare di Piazza (1983) e di Gela (1990 e 1997) alla storia dell’ambiente (1985 e 1989), dai rapporti tra scienze e Gesuiti (1991 e 1992) alla pittura nel nisseno (2000), per non fare riferimento che ai più rilevanti volumi pubblicati.
Forse a distoglierlo fu anche l’impegno dedicato all’attività ambientalista con Italia Nostra, la cui sezione provinciale aveva fondato appena uscito dalla convalescenza.
È mia impressione che le successive sue ricerche sulla storia di Piazza avevano reso meno significativi i capitoli compilativi: l’introduzione con i cenni storici e il secondo capitolo con le schede delle chiese ufficialmente censite dalla Diocesi in quel 1967. Certamente pensò che si sarebbe reso necessario un ulteriore lavoro di approfondimento e riscrittura al quale, probabilmente, non volle applicarsi. Oppure, più semplicemente, aveva perso interesse per quell’argomento che invece, a cinquanta anni di distanza, e pur con quel carattere datato sia nello stile (un ampio ricorso delle maiuscole, per esempio, che in seguito avrebbe abbandonato o l’uso del termine “folklore” nella sua acezione originaria, come insieme delle tradizioni popolari di un ambito territoriale in tutte le manifestazioni culturali che ne sono espressione) che nei riferimenti bibliografici, conserva ancora un interesse tutt’altro che secondario perché rimane ancora inesplorato il rapporto tra istituzioni religiose e religiosità popolare in una città in cui oggi sia le prima che le seconde vivono una fase di profonda crisi. Le prime per la drammatica crisi delle vocazioni in una più generale fase di grande cambiamento del ruolo della chiesa nella società contemporanea, la seconda perché il virus della disneylandizzazione e dell’esibizione sembra avere contagiato irrimediabilmente molte delle sue espressioni più autentiche.
Per questo motivo la famiglia, insieme a Ina Roccaverde, Presidente dell’Università Popolare del Tempo Libero intitolata a Ignazio Nigrelli, ha deciso di dare alle stampe, in occasione del duecentesimo anniversario della erezione della Diocesi, questo testo inedito.
Ringraziamo Mons. Rosario Gisana, dodicesimo Vescovo di Piazza Armerina per la postfazione; il dott. Gigi Lentini, la prof. Salvina Ciffo Arena … per avere messo a disposizione le fotografie in loro possesso.
Fausto Carmelo Nigrelli
Ignazio Nigrelli (Leonforte, 1926 – Piazza Armerina, 2000) è stato uno storico, saggista e ambientalista italiano, si è occupato di storia della Sicilia e di tutela dei beni culturali e ambientali.
Primogenito di una famiglia numerosa, da padre operaio stradale e madre casalinga, si forma in diverse città dove il padre svolge il suo lavoro. Frequenta il liceo classico "Eschilo" a Gela e poi si iscrive alla Facoltà di Lettere dell'Università di Catania, dove si laurea in Lettere moderne nel 1950, con una tesi sulla fondazione federiciana di Terranova, sotto la direzione di Gina Fasoli. Dopo essersi occupato, nei primi anni dopo la laurea, di storia medievale come assistente della stessa Fasoli, prima e di Giuseppe Giarrizzo, poi, si dedica all'attività di docente nelle scuole superiori e, per un trentennio, all'attività politica. Già dal 1946, infatti, era iscritto al Partito Comunista Italiano e nel biennio 1952-53 aveva partecipato, con altri giovani universitari, all'occupazione delle terre della piana di Gela insieme ai braccianti organizzati dalla Camera del Lavoro diretta da Paolo La Rosa. Dal 1961 al 1976 viene sempre eletto come al Consiglio Comunale di Piazza Armerina nelle liste del PCI, partito nel quale riveste anche incarichi di dirigente provinciale.
Lasciata l'attività politica militante per motivi di salute, torna alla giovanile passione per gli studi storici (che in realtà non aveva mai del tutto abbandonato) e individua nell'azione ambientalista l'attività che mette insieme l'importanza della conoscenza e la proiezione nel futuro.
Fonda a Piazza Armerina nel 1977 la sezione di Italia Nostra, Associazione nazionale per la tutela del patrimonio storico artistico e naturale, di cui rimane presidente fino alla sua scomparsa.
Nel 1989, al momento delle prime elezioni di un Presidente del Consiglio Regionale Siciliano di Italia Nostra, viene eletto a quella carica che ricopre fino al 1996. Nella sua veste di storico e ambientalista ha partecipato a diversi organismi. In particolare, dal 1994 al 1995, ha partecipato ai lavori del Comitato Stato-Regione-Enti Locali-Ambientalisti per l'esame del Piano di Risanamento dell'area ad elevato rischio ambientale di Gela. Dal 1995 ha fatto parte del Comitato Tecnico Scientifico dell'Ente parco minerario di Floristella-Grottacalda, in provincia di Enna, di cui è stato anche Vice Presidente.
A partire dal 1994 è stato dirigente e docente dell'Università popolare del tempo libero di Piazza Armerina che ha contribuito a fondare e che gli è stata intitolata dopo la sua scomparsa (http://www.universitapopolarenigrelli.it). Nell'ambito dell'attività svolta da questa associazione ha tenuto numerose conferenze, pubblicato saggi e libri. È stato Direttore scientifico del progetto realizzato in collaborazione con la Sezione di Italia Nostra e il Distretto Scolastico 27 dal titolo "Opere d'arte di Piazza Armerina scomparse, disperse, a rischio" che ha prodotto una brochure di presentazione, una mostra fotografica e un video. È stato Direttore scientifico del progetto realizzato in collaborazione con la Sezione di Italia Nostra e il Distretto Scolastico 27 dal titolo "Per non dimenticare: ricordi dei reduci della II guerra mondiale" che ha prodotto un volume, una mostra fotografica e un video.
Tra i suoi principali volumi pubblicati:
· Piazza Armerina medievale. Note di vita artistica, sociale e culturale del XII al XV secolo, Electa, Milano, 1983;
· Scuola e ambiente in Sicilia. La ricerca ambientale delle realtà locali, Ila Palma, Palermo, 1985;
· L'ambiente naturale. Conservazione, degrado, restauro, Ila Palma, Palermo, 1986;
· Piazza Armerina: l'ambiente naturale, la storia, la vita economica e sociale, Ila Palma, Palermo, 1989;
· Filippo Arena e la cultura scientifica del Settecento in Sicilia, Ila Palma, Palermo, 1991;
· La cultura scientifica e i Gesuiti nel Settecento in Sicilia, Ila Palma, Palermo, 1992;
· (con Liliane Dufour) Terranova: destino della città federiciana- Gela e il suo territorio dal XIII sec. ai nostri giorni, Caltanissetta, 1997;
· Piazza Armerina nella letteratura, Piazza Armerina 1997;
· Viaggiatori stranieri a Piazza Armerina e nella Sicilia interna dal XVI sec. all'unità d'Italia, Piazza Armerina 1999;
· Per non dimenticare. Testimonianze di reduci della Seconda Guerra Mondiale, Piazza Armerina, 2000;
· (con altri) La pitture nel nisseno, Sciascia ed., Caltanissetta, 2000.
Ha inoltre scritto parte dei testi della Guida Touring Club Italiano della provincia di Enna intitolata "Enna e la sua provincia".
Nel novembre 2000 l'Università popolare del tempo libero di Piazza Armerina è stata intitolata a Ignazio Nigrelli e, per l'occasione, è stato pubblicato il volume
· Ignazio Nigrelli, uomo giusto e libero che contiene il testo dell'orazione funebre tenuta da Filippo Acquachiara.
Nel 2010 il Dipartimento ASTRA dell'Università di Catania ha pubblicato l'antologia
· Ignazio Nigrelli, La storia onesta. Saggi di storia medievale su Augusta, Gela e Piazza, Lombardi editori, Siracusa.
I saggi principali:
· "La crisi dell'industria zolfifera siciliana in relazione al movimento dei Fasci", in Movimento Operaio, rivista di storia e bibliografia, nuova serie, n. 6, "I Fasci siciliani", nov.-dic. 1954 (a.VI), edito a cura della biblioteca G.G. Feltrinelli, pp. 1050 - 1066;
· "I Trigona di Piazza Armerina. Appunti per la storia di una famiglia feudale siciliana dal XIV al XVIII secolo", in S. Parisi (a cura di), L'Archivio Trigona di Canicarao. Piazza e la sua nobiltà fra XVI e XVIII secolo, Archivio di Stato, Enna, 1986, pp. 11-23.